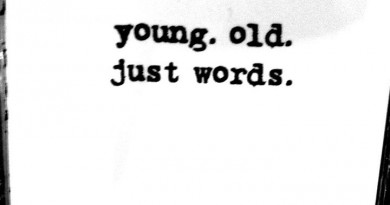Discriminazione di genere,Tribunale di Pisa, sentenza del 17 luglio 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Pisa
dott.ssa Elisabetta Tarquini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 1006/2012 RG., discusse all’udienza del 17.7.2013
promossa
da M. S. elettivamente domiciliata in Pisa, Via S. Orsola n. 34, presso lo studio dell’Avv. Giulio Giraudo, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
e da Consigliera di Parità della provincia di Pisa Avv. Clara Fanelli, elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, presso lo studio dell’Avv. Chiara Federici, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
contro
A E titolare dell’impresa individuale denominata B. M., elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56, presso lo studio dell’Avv. Maria Fernanda Ventura, che la rappresenta e difende per mandato a margine della memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2012 S. M. e la Consigliera di parità della Provincia di Pisa Avv. Clara Fanelli convenivano davanti a questo giudice del lavoro E. A., titolare dell’impresa individuale denominata B. M., allegando essere stata M dipendente della convenuta (con mansioni di apprendista banconiera livello IV del CCNL commercio ed orario di lavoro part time) dal 1°.4.2009 fino al 25.9.2011 quando il rapporto si era risolto ad iniziativa della datrice di lavoro per giustificato motivo soggettivo e con esonero della lavoratrice dal preavviso lavorato e corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
A fondamento del recesso la società assumeva i fatti contestati con lettera datata 30.6.2011, essi consistenti nell’avere la lavoratrice, il giorno 22.6.2011 mentre si trovava assente per malattia, affermato, durante una conversazione con una cliente abituale dell’esercizio che A “era una persona cattiva, invidiosa e che parla male dei clienti” e che “tutti ormai se ne stanno rendendo conto, così che nessuno frequenterà più il bar”.
Le ricorrenti contestavano la legittimità del licenziamento, sia per non avere M proferito le frasi che le erano state attribuite, sia comunque per essere i fatti de quibus inidonei a costituire il dedotto giustificato motivo di recesso, recesso del quale la lavoratrice e la Consigliera di parità argomentavano piuttosto la natura discriminatoria per motivi di genere.
Sul punto più specificamente allegavano essere M madre di una bambina nata il 18.9.2010 ed essere stato pertanto intimato il recesso solo quattro giorni dopo il compimento dell’anno di età della bambina (e la conseguente cessazione del periodo di interdizione del licenziamento ex art. 54 del D.L.vo 151/2001).
La determinazione datoriale peraltro, secondo la prospettazione attrice, sarebbe maturata ben prima della formalizzazione del provvedimento espulsivo, come sarebbe stato desumibile: a) dal fatto che la lavoratrice, durante il periodo di astensione per maternità, fosse stata fatta oggetto di “ripetuti e pubblici apprezzamenti negativi da parte della convenuta”, che si sarebbe mostrata insofferente al proprio obbligo di corrisponderle le dovute indennità per la durata dell’assenza; b) dalla circostanza che A avesse comunicato a M, con lettera datata 14.9.2011, il mutamento dell’orario di lavoro fino all’inizio dell’astensione osservato dalla lavoratrice, richiedendone la prestazione non più dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 15,30, ma dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 20, un frazionamento idoneo a rendere la conservazione della relazione negoziale per l’odierna attrice particolarmente gravosa data la sua condizione di madre ed attesa anche la distanza della sua abitazione dal luogo di lavoro; c) dal fatto che la convenuta avesse assunto, nel periodo di assenza di M ed in sua sostituzione, una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato.
Premessi questi fatti le ricorrenti concludevano, in tesi, per l’affermazione del carattere discriminatorio del recesso, con le conseguenze di cui all’art. 18 della L. 300/1970 (nel testo previgente l’entrata in vigore della L. 92/2012, essa inapplicabile ratione temporis) e la condanna della convenuta altresì a risarcire a Ml’ulteriore danno da lei patito in conseguenza della dedotta discriminazione, che quantificavano nella misura di € 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
In ipotesi le difese attrici chiedevano affermarsi l’illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo e ne chiedevano l’annullamento con le conseguenze di cui all’art. 8 della L. 604/1966, applicabile attesa la consistenza occupazionale dell’impresa della convenuta.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, resisteva la convenuta contestando la dedotta discriminazione, negando di aver mai avanzato alcuna rimostranza o obiezione a fronte delle scelte di vita della ricorrente anche nelle occasioni nelle quali la stessa, durante il periodo si astensione, si era recata in azienda per ritirare le buste paga, ed affermando di avere assunto una lavoratrice in sostituzione di M, durante la sua assenza per maternità, non a tempo indeterminato, ma a chiamata.
Quanto alla modifica dell’orario ne deduceva la necessità in dipendenza della riduzione dell’afflusso di clientela, che si sarebbe concentrata nelle fasce orarie dei pasti.
Assumeva essere stata motivato il recesso piuttosto dalle condotte ingiuriose e diffamatorie che la ricorrente avrebbe tenuto in suo confronto con clienti abituali dell’esercizio, condotte che affermava “ripetute”.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita con l’escussione di alcuni dei testi indotti dalle parti e con l’acquisizione di alcuni documenti.
Infine, all’udienza indicata in epigrafe, dopo aver redatto note scritte, i difensori discutevano, riportandosi ai loro atti ed il giudice pronunciava sentenza come da separato dispositivo di cui dava lettura attesa la complessità delle questioni trattate.
Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito pare alla decidente che la domanda svolta in via principale sia fondata per essere stato il licenziamento dell’attrice comunicato dopo, ma certamente programmato prima della scadenza dell’anno di interdizione ex lege 151/2001, nel corso di tale periodo la convenuta avendo assunto “misure preparatorie” di quella decisione (per questa locuzione cfr. Corte di Giustizia, 11.10.2007, Paquay, di cui più ampiamente infra), alcune di esse per vero ex se illecite, in quanto obiettivamente idonee ed inequivocamente dirette a rendere l’esecuzione della prestazione particolarmente gravosa per lavoratrice madre così da indurla a dismettere lei stessa la relazione negoziale de qua.
Ed invero è un fatto che il licenziamento impugnato sia stato intimato con lettera datata 22.9.2011, successiva quindi la formazione della comunicazione di recesso di soli quattro giorni al compimento dell’anno di età della figlia della ricorrente.
E’ del pari documentato che A abbia assunto una lavoratrice (N M, sentita come teste in giudizio), pacificamente in sostituzione di M, con due successivi contratti a chiamata, il primo avente convenuta durata 11.10.2010 – 31.12.2010 prorogato fino al 30.4.2011, il secondo stipulato invece il 22.7.2011 ed avente durata annuale (più esattamente con scadenza al 31.7.2012), esso quindi, non solo concluso ab origine per un periodo ben più lungo del primo, per quanto la cessazione dell’astensione dell’attrice fosse assai più prossima, ma destinato a scadere in data ben successiva al programmato rientro di M dalla maternità (che avrebbe dovuto avvenire il 19 settembre 2011, come pacifico).
Neppure allegata in memoria la determinazione della convenuta di avvalersi della prestazione di entrambe le lavoratrici, secondo la disciplina dei loro diversi rapporti di lavoro, all’esito della ripresa dell’attività da parte della ricorrente (la circostanza essendo in contrario senz’altro esclusa dall’affermazione contenuta in memoria di una contrazione dell’attività aziendale in essere nel settembre 2011), deve allora di necessità ritenersi che A intendesse impiegare unicamente la prestazione della nuova assunta pur dopo il settembre 2011, non essendovi alcuna diversa attendibile spiegazione della durata del secondo contratto di assunzione con lei stipulato, a fortiori considerato come la stessa Macchi abbia dichiarato in giudizio di avere lavorato dal luglio 2011 continuativamente.
Ma ancor più rileva ai fini di interesse la circostanza della unilaterale determinazione della convenuta di modificare l’articolazione dell’orario della ricorrente al suo rientro dalla maternità, richiedendole, con lettera 14.9.2011 (e quindi in data antecedente la cessazione del periodo di interdizione), di lavorare non più dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 15,30, come sempre accaduto prima dell’inizio dell’astensione, ma dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, dalle 15 alle 16 e dalle 17 alle 20, un frazionamento all’evidenza idoneo a rendere la conservazione della relazione negoziale per l’odierna attrice particolarmente gravosa, data la sua condizione di madre, anche in ragione della distanza dell’abitazione familiare (sita in Cascina, come incontestato) dal luogo di lavoro.
E che l’articolazione oraria della prestazione fosse, non solo obiettivamente idonea a pregiudicare l’adempimento dei doveri parentali della lavoratrice, così da indurla ragionevolmente a recedere lei stessa dal rapporto negoziale controverso, ma anche effettivamente diretta ad una tale finalità, pare alla decidente certo ove si consideri che un simile orario non era stato richiesto a M prima dell’inizio dell’astensione e non è stato richiesto dopo alla lavoratrice che l’ha sostituita (la teste M). Il contratto di lavoro a termine part time stipulato da A con N. M. il 1°.8.2012 (senza soluzione di continuità, quindi, rispetto ai contratti a chiamata sopra menzionati) reca infatti l’indicazione di un orario non sostanzialmente diverso, quanto alla sua dislocazione nell’arco della giornata, rispetto a quello originariamente pattuito con M (segnatamente 11,30-14,30), mentre nessuna deduzione di prova è in memoria quanto all’affermata relazione tra la variazione dell’orario dell’attrice nel settembre 2011 e la modificazione della consistenza del lavoro aziendale, essa affermata peraltro del tutto genericamente.
Da tutti gli elementi di fatto appena detti pare allora alla decidente debba univocamente desumersi essersi determinata la convenuta a dismettere il rapporto negoziale di cui è causa assai prima della data di intimazione del recesso, e quindi durante il periodo di interdizione, in detto periodo ella essendosi attivata per sostituire la ricorrente ben oltre il periodo di astensione ed avendo altresì inteso agire al fine di indurla a recedere lei stessa, rendendole particolarmente gravoso il contemporaneo adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e dei doveri parentali.
Una condotta quest’ultima peraltro ex se illecita in quanto senz’altro discriminatoria per motivi di genere nel senso, proprio della nozione secondo il diritto dell’Unione, di trattamento deteriore riservato ad una lavoratrice madre rispetto ad altri lavoratori non portatori del fattore di protezione (segnatamente lei stessa prima dello stato di gravidanza e la teste Macchi, addetta alle sue stesse mansioni) e non altrimenti giustificato, attesa l’assenza anche di ogni deduzione a prova del diverso andamento dell’attività aziendale nei differenti periodi di interesse.
E ciò detto è noto come la Corte di Giustizia abbia ritenuto che “l’art. 10 della direttiva 92/85 deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento a causa della gravidanza e/o della nascita di un figlio durante il periodo di tutela definito al suo n. 1, ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione prima della scadenza di detto periodo” (così testualmente Corte di Giustizia, 11.10.2007, Paquay).
D’altro canto il legislatore dell’Unione, come quello nazionale, ha certamente affermato la presunzione della relazione causale tra recesso e maternità nel periodo di interdizione, la detta relazione dovendo presumersi, indipendentemente dall’intento soggettivo del datore di lavoro, salvi “i casi eccezionali non collegati allo…stato” di gravidanza della lavoratrice (così testualmente Corte di Giustizia, Paquay cit., 31), nel nostro ordinamento, quanto al licenziamento disciplinare, limitati alla giusta causa.
Ipotesi questa che certamente non si dà nella specie, già secondo l’apprezzamento della datrice di lavoro che ha intimato il licenziamento per giustificato motivo, seppure con esonero della lavoratrice dal preavviso.
Deve pertanto concludersi essere stato deliberato e programmato il recesso impugnato nel periodo di interdizione ex lege 151/2001 ed intimato al di fuori delle ipotesi normative di eccezione al divieto di licenziamento delle lavoratrici madri.
Dati questi fatti, ne segue la certa nullità del licenziamento ex art. 54 del D.L.vo 151/2001.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie della violazione, pare poi alla decidente che, pur inapplicabile ratione temporis la disciplina contenuta nell’art. 18 della L. 300/1970, come modificata dalla L. 92/2012 (che espressamente afferma l’applicabilità della detta norma anche al licenziamento della lavoratrice madre), non di meno anche nella specie trovi applicazione la disciplina sanzionatoria di diritto speciale prevista dal testo dell’art. 18 vigente all’epoca di intimazione del recesso.
E ciò in esito alla necessaria qualificazione come discriminatorio del licenziamento intimato alla lavoratrice madre, l’applicazione della sanzione di diritto speciale derivando di conseguenza dalla piana applicazione dell’art. 3 della L. 108/1990.
Una tale soluzione ermeneutica pare infatti a questo giudice imposta dal diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia, che anche di recente ha ricostruito la protezione contro il licenziamento delle lavoratrici in gravidanza come necessariamente implicata dal principio di non discriminazione per ragioni di genere, all’evidenza il recesso intimato alle lavoratrici in detto periodo costituendo un trattamento deteriore che può riguardare soltanto le donne e che costituisce quindi una discriminazione diretta basata sul sesso (in tal senso da ultimo ancora Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11.10.2007, Paquay, secondo cui “prima dell’entrata in vigore della direttiva 92/85, la Corte aveva già statuito che, in forza del principio di non discriminazione, e in particolare degli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, una protezione contro il licenziamento doveva essere riconosciuta alla donna non soltanto durante il congedo di maternità, ma anche per l’intero periodo della gravidanza. Ad avviso della Corte, un licenziamento durante tali periodi può riguardare solo le donne e costituisce quindi una discriminazione diretta basata sul sesso”, così anche la giurisprudenza del giudice del’Unione ivi citata: sentenze 8 novembre 1990, causa C‑179/88, Handels‑ og Kontorfunktionærernes Forbund, Racc. pag. I‑3979, punto 15; 30 giugno 1998, causa C‑394/96, Brown, Racc. pag. I‑4185, punti 24-27, e McKenna, cit., punto 47).
Né ai fini della identificazione della fattispecie discriminatoria ha alcun rilievo l’intento soggettivo del datore di lavoro (id est l’esistenza o la prova di una sua determinazione di recedere a causa dello stato di gravidanza), il divieto di discriminazione (nella specie per motivi di genere) operando obiettivamente, in ragione della oggettiva necessità di tutela connessa al fattore di protezione, e quindi ex se per effetto dello stato di gravidanza.
Alla declaratoria della nullità del licenziamento impugnato deve seguire allora la condanna della convenuta a reintegrare M nel proprio posto di lavoro ed a risarcirle il danno derivante dal recesso nella misura di tante mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto quante ne decorrono dal licenziamento all’effettiva reintegra.
Il capitale così dovuto dovrà essere, poi, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalle singole scadenze a decorrere dalla data licenziamento e fino al saldo.
All’annullamento del recesso segue inoltre ex lege la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.
Deve infine apprezzarsi della fondatezza della domanda attrice diretta al risarcimento dell’ulteriore danno non patrimoniale affermato come conseguente alla dedotta natura discriminatoria del recesso.
In proposito pare in primo luogo a questo giudice che alla qualificazione del licenziamento della lavoratrice madre come comportamento ex se discriminatorio segua l’applicazione anche ad esso del peculiare regime rimediale previsto avverso le discriminazioni dagli artt. 37 e 38 del D.Lvo 198/2006 (che richiama espressamente, oltre alle discriminazioni di cui al capo II del Libro II del decreto, anche ogni altra discriminazione tra l’altro relativa alle “condizioni di lavoro”) e che consente il risarcimento anche del danno non patrimoniale.
Ritenuta quindi l’astratta risarcibilità nella specie del pregiudizio non patrimoniale di cui in ricorso, quanto alla prova della sua esistenza ed alla relativa quantificazione, deve ribadirsi, anche ai fini che ora interessano, come quella delle discriminazioni di genere sia materia (e per vero materia d’elezione) di diritto dell’Unione (da ultimo con la direttiva 2006/54, ricognitiva delle precedenti fonti comunitarie).
Di qui l’obbligo del giudice nazionale di adottare della normativa interna (e quindi già degli artt. 37 e 38 del D.Lvo 198/2006) una interpretazione, tra le diverse consentite dal tenore della disciplina medesima, conforme al testo ed agli obiettivi delle direttive (v. già Corte giust., 10 aprile 1984, causa c-14/83, Van Colson e Kamann; più recentemente, tra le altre, Corte giust., 13 novembre 1990, causa c-106/89, Marleasing, 15 maggio 2003, causa c-160/01, Mau, e 4 luglio 2006, causa c-212/04, Adeneler), in caso diverso, e quindi ove il giudice nazionale constati l’impossibilità di pervenire ad una soluzione ermeneutica conforme alle direttive de quibus, egli essendo tenuto a non applicare la disposizione interna difforme, per dare integrale attuazione all’ordinamento europeo e proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (Corte giust., 2 maggio 2003, causa c-462/99, Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation).
Ora, nella specie è noto come l’art. 18 della direttiva 2006/54 CE obblighi gli Stati membri ad introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali le misure necessarie per garantire, per il danno subito da una persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso, “un indennizzo o una riparazione reali ed effettivi, da essi stessi stabiliti in modo tale da essere dissuasivi e proporzionati al danno subito. Tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale stabilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l’unico danno subito dall’aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda”.
La fonte sovranazionale quindi attribuisce allo strumento rimediale del risarcimento del danno connotati necessari di effettività, essi tuttavia rapportati, non solo alla gravità del pregiudizio, ma anche alla funzione dissuasiva e sanzionatoria della qualificata riparazione.
E non può dubitarsi che una tale qualificazione incida sul regime della prova del diritto nell’an e sulla sua quantificazione, l’obbligo di liquidare il risarcimento dandosi, ove come nella specie richiesto, anche in funzione della finalità dissuasiva di ulteriori violazioni implicata dal rimedio.
Ciò detto, facendo applicazione dei detti principi nella specie, deve rilevarsi come la discriminazione, rappresentata nella specie dal licenziamento deliberato e programmato nel periodo di interdizione ex lege 151/2001, segua ad una condotta datoriale, specificamente la variazione dell’orario, non solo obiettivamente idonea, ma dolosamente diretta a rendere particolarmente gravosa proprio per la lavoratrice madre (id est per la ricorrente in quanto madre lavoratrice) l’esecuzione della prestazione.
La violazione del divieto di licenziamento ex art. 54 del D.Lvo 151/2001 costituisce allora la più rilevante, ma non l’unica condotta datoriale specificamente contraria ai divieti di discriminazione, la cui ulteriore ripetizione deve essere evitata a mezzo dello strumento rimediale espressamente approntato dalla fonte sovranazionale anche a fini dissuasivi.
Ne segue l’esistenza nell’an del diritto della lavoratrice al risarcimento del danno non patrimoniale rivendicato in ricorso.
Quanto alla sua determinazione la decidente è peraltro ben consapevole dell’ineliminabile ambiguità di ogni criterio di quantificazione, attesa l’ontologica “incommensurabilità” economica del danno non patrimoniale, rispetto al quale il risarcimento per equivalente monetario non può essere che una fictio juris, non di meno indispensabile a consentire una tutela minima necessaria dei diritti inviolabili della persona.
E’ quindi nella consapevolezza di una tale complessità di valutazione che questo giudice ritiene di quantificare il risarcimento dovuto a M in € 2.500,00, misura da ritenersi adeguatamente compensativa delle violazioni subite dalla lavoratrice ed idonea ad assumere una qualche efficacia dissuasiva attese le dimensioni aziendali.
Le spese processuali, come infra liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l’art. 429 c.p.c, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento delle conclusioni svolte in tesi in ricorso, ritenuta la discriminatorietà del licenziamento impugnato, ne dichiara la nullità e condanna la convenuta a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a risarcirla del danno derivante dall’illegittimità del recesso nella misura di tante mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto quante ne decorrono del recesso fino all’effettiva reintegrazione, maggiorato il capitale così dovuto di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalle singole scadenze retributive fino al saldo. Condanna altresì la convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale della ricorrente.
Condanna la convenuta al risarcimento del danno ex lege 11.4.2006 n. 198 nella misura di € 2.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (calcolati gli interessi sulla somma capitale mensilmente rivalutata) dalla data della presente decisione al saldo
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore delle ricorrenti, che liquida, quanto ad entrambe le posizioni in solido, in € 5.000,00 compenso di avvocato ex DM 140/2012, oltre IVA e CAP come per legge.
Motivazione nei sessanta giorni
Pisa, 17.7.2013